100 CUSTODI PER 100 VITIGNI, LA BIODIVERSITÀ VITICOLA IN ITALIA a cura di Aldo Lorenzoni; testi di Aldo Lorenzoni, Luigino Bertolazzi, Giuseppe Carcereri De Prati, Gianmarco Guarise, Ivano Asperti, Giacomo Eccheli, Elia Quarzago, Marta De Toni, Theresa Balaara
La missione principale dell’Associazione G.R.A.S.P.O, è di coltivare i 100 vitigni che vi presenteremo in una serie di articoli che sono a rischio di estinzione e di raccontarvi le aziende che stanno effettuando questi esperimenti per salvaguardare le specie che altrimenti andrebbero perdute.

Walter Massa e il Timorasso di Luigino Bertolazzi
Incontrare Walter Massa, il profeta del Timorasso, in giro per l’Italia e non solo, non è molto difficile: manifestazioni promozionali, fiere di settore, degustazioni particolari, presentazioni di vini o libri. Se sei curioso, motivato e fortunato ecco che lo incontri, ma se lo cerchi a casa sua a Monleale di Volpedo devi essere molto raccomandato perché se non è in cantina è in vigna o il più delle volte… non si sa dov’è.
Se Walter è a casa, prima di farti entrare, ti porta a vedere uno scorcio dei suoi vigneti più suggestivi per poi insegnarti come si fa correttamente una scacchiatura e una selezione dei grappoli a verde sul suo vitigno del cuore il Timorasso. Ti insegna che il Timorasso, essendo di buona produttività da ogni gemma a frutto origina mediamente da due fino a quattro germogli. Walter proviene da una famiglia contadina dei colli Tortonesi, la famiglia Massa abitava infatti in località La Morena che era l’ultima casa di Monleale. La realtà agricola della zona era una volta caratterizzata da una agricoltura mista oltre alla vigna c’era il frutteto e l’allevamento. Le uve coltivate allora erano: il Timorasso, il Citronino e il Cortese per i bianchi mentre per i rossi la Barbera il Dolcetto e un’uva chiamata Cenerina.
La situazione dopo la catastrofe filosserica cambia radicalmente, la coltura del vino si perde a favore della coltura della pesca e dell’allevamento. Pochi filari di uve di diverse varietà per produrre vini generici bianchi e rossi per l’auto consumo o il consumo di prossimità, una situazione destinata però presto a cambiare.
Lo zio Genesio Boveri aveva nel 1970 acquistato proprio alla sommità del paese un vigneto, ancora produttivo, dove diverse varietà convivevano, fra queste anche alcune vigne di Timorasso. È fra le viti di zio Genesio che Walter trova le marze per moltiplicarle e piantare un vigneto di Timorasso in purezza tra il biasimo dei tanti coltivatori che allora non avevano particolare considerazione per questo vitigno chiamato letteralmente ‘rasin de merd’.
Walter è conscio della sfida, ma non demorde e prosegue nel percorso di valorizzazione del Timorasso che comincia a vinificare in purezza e a commercializzare. Ma sono gli anni successivi, quelli che segnano un cambio di passo nella coltivazione del vitigno che incrementa le superfici da pochi ettari a più dei 200 attuali, coinvolgendo in questa nuova avventura tanti viticoltori del territorio.
Nella monumentale opera che Jancis Robinson pubblica nel 2012 alla parola Timorasso si parla di qualche decina di acri di superficie, associando al vitigno il nome di Walter Massa e dello zio che neanche credeva inizialmente a quello che sarebbe diventato il fenomeno Timorasso.
Il resto è storia recente e sarebbe inutile raccontare di come Walter diventa un simbolo guidando la riscossa di questo vitigno anche qualificandolo con il nome dei singoli vigneti posti in varie zone vocate.
Un uomo del fare e della concretezza dato che per lui ogni traguardo raggiunto diventa motivo per una sempre nuova ripartenza.
Il suo è un successo riconosciuto ed apprezzato da tanti, anche dai suoi detrattori, un successo portato con la leggerezza e l’entusiasmo dell’eterno neofita.
Una storia che ha dato il la a molti produttori, anche nell’Albese, che hanno iniziato a coltivare questo vitigno considerato originalmente un ‘bastardo’. Una storia che si ripete, e che abbiamo ritrovato nel ‘Manualetto popolare del Viticultore’ del 1898 riprodotto da Walter e scritto da Luigi Cataldi che è stato una memoria storica della viticoltura Tortonese, tanto interessante quanto attuale, per dire che se vuoi andare avanti non ti devi mai scordare e radici”.
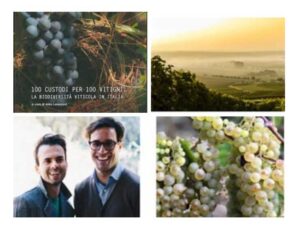
Davide, il Conte ed il Ruzzese di Arcola di Aldo Lorenzoni
Arcola è un piccolo paese arroccato nell’entroterra di La Spezia. È da sempre Città del Vino, sia per la particolare vocazione del sito ad una viticoltura di qualità, che per il profondo legame con il Ruzzese, un singolare antico vitigno autoctono a bacca bianca storico di questo territorio.
Un vitigno che abbiamo rischiato di perdere ma fortunatamente prima salvato dalla tenacia del conte Nino Picedi Benettini, ed oggi valorizzato dalla giovane azienda Ca du Ferrà di Davide Zoppi a Bonassola, racconta Enzo Giorgi amministratore ad Arcola. Dalla gloria all’oblio. Il primo riferimento storico al Ruzzese risale al 6 gennaio 1736 in un atto deliberativo nella Corte di Arcola che lo cita come vino per doni o celebrazioni, testimoniando quindi che era considerato un vino di pregio.
Vero che fu apprezzato anche molto prima nel 1500 da Papa Paolo III Farnese nella sua versione passita, ma vera traghettatrice del vitigno attraverso i secoli fu la nobile famiglia dei Picedi presente sul territorio già dal XII secolo. Era proprietaria di molti terreni sulle colline di Arcola, coltivate con vitigni di tradizione ligure e della confinante Toscana come Vermentino, Albarola, Ruzzese appunto, Pollera e Vermentino Nero. L’avvento della fillossera agli inizi del ’900 fu però un colpo durissimo per questo vitigno che negli anni della ricostruzione viticola fu sistematicamente sostituito dalla varietà Bosco molto più produttiva.
Cruciale per la sua conservazione fino ai giorni nostri è stata la figura del Conte Nino Picedi Benettini (1927 – 2019), coinvolgendo in questa missione gli amministratori
locali e la Regione Liguria. Così con la collaborazione tecnica del Prof. Mannini e di Anna Schneider del CNR di Torino, non solo è stata accertata l’originale identità del vitigno ma è stata possibile la sua iscrizione nel Registro del Ministero nel 2019.
Un percorso di salvaguardia e recupero che vede oggi protagonista anche l’azienda Ca du Ferrà di Bonassola nella Liguria di levante. Fatale un convegno sui vitigni dimenticati a Vernazza nelle Cinque Terre, dove Davide Zoppi e Giuseppe Luciano Aieta, suo compagno nella vita e nel lavoro, incontrano per la prima volta il Ruzzese
Bianco decidendo subito di investire nel recupero di questa storica varietà. Si arriva così al 2015, quando Davide e Giuseppe decidono di piantare le prime 77 barbatelle di Ruzzese, che nei cinque anni successivi diventeranno 1.500, fino a ricoprire cinque terrazze a sbalzo sul mare nella zona dei piani di Cà du Ferrà, dove crescono le uve che danno corpo ai vini più pregiati dell’azienda.
L’area di coltivazione del Ruzzese oggi è nella zona della Spezia e, più in generale, dell’estremo levante ligure. La sua diffusione è ancora molto limitata probabilmente a causa della grande fortuna incontrata dal Vermentino, decisamente più produttivo, ma anche della difficoltà di reperire sul territorio microclimi idonei alla resistenza del vitigno molto sensibile a umidità e freddo.
Questa varietà va distinta dal Rossese Bianco dell’Alta Langa in Piemonte e dal Rossese a bacca rossa tipico invece del ponente ligure. La sua caratteristica peculiare è che la buccia di colore giallo verde assume una colorazione rossastra quando giunge a piena maturazione. Il suo nome, Rossese Bianco, potrebbe derivare da questo fatto.
Davide e Giuseppe hanno deciso anche di ripercorrere la strada del passato reinterpretando il vitigno anche in chiave passito. Dopo la vendemmia tardiva, infatti, i grappoli sono stati disposti manualmente sopra delle cassette e lasciati appassire per circa due mesi e mezzo, procedendo poi con la sgranatura manuale e la vinificazione in bianco, a partire dai primi giorni di dicembre. Il risultato sono solo poche centinaia di bottiglie per un vino passito profumatissimo, morbido e avvolgente, che mantiene una beva agile e sbarazzina, a dispetto del suo grado alcolico intorno ai 14% vol. Il nome scelto per questa nuova etichetta è Diciassettemaggio.
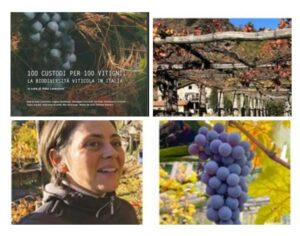
Bianca, Riccardo, i Pilùn ed il Nebbiolo Picotendro di Luigino Bertolazzi
La storia delle piccole aziende è legata alle persone, e le persone di questo caso sono Riccardo Prola e Bianca Seardo, che dopo anni di lavoro, come tecnico lui e come ricercatrice esperta di paesaggio lei, hanno deciso di abbandonare la loro attività per ricominciare insieme rigenerando una vigna storica. Bianca e Riccardo sono coppia nella vita, una relazione che si è consolidata con una avventura nuova, a contatto con la natura, con l’obiettivo di recuperare il fondo agricolo di famiglia. Siamo nel Canavese a Settimo Vittone, nell’anfiteatro di Ivrea a due passi dal forte di Bard, il punto più stretto della valle che passando dalla Valle d’Aosta porta in Francia, dove hanno dato vita all’azienda Figliej. Terra dura dove ogni pezzetto coltivabile è stato strappato alla montagna, con lavori di terrazzamento e costruzione di muri a secco che hanno dell’incredibile. Il sistema di allevamento è la pergola Canavese o meglio Topia Canavese, con i suoi caratteristici sostegni in pietra di granito intonacata con calce (i Pilun), mentre la struttura orizzontale è fatta con legno di castagno tagliato nella luna adatta. La storica pergola canavesana era allestita e curata durante l’inverno dagli uomini ed era coltivata in primavera ed in estate dalle donne, perché durante la bella stagione i maschi si trasferivano in Francia a fare i muratori. In inverno i giovani canavesi tornavano a casa e, con le mine e tanta fatica, strappavano ogni anno un pezzo di terra alla montagna. Sono opere straordinarie, sintesi di un’agricoltura rispettosa del territorio, soprattutto della tutela idraulica dei luoghi. A Settimo Vittone, come in tutta la conca del Canavese, ogni terrazzamento ha un nome, e tutti insieme abbracciano la via Francigena che passa proprio sotto alle suggestive pergole. È una viticoltura molto ricca in biodiversità con quasi venti varietà originali disperse in modo casuale in mezzo ai vigneti. Il Nebbiolo Picotendro è una delle varietà più antiche e identitarie, aveva allora una superficie complessiva di 60 ettari ora ridotta a 30 ettari, anche se si notano però incoraggianti segni di recupero. Picotendro, così lo chiamano nella bassa valle condivisa dalla Valle d’Aosta e dal Piemonte, un Nebbiolo a tutti gli effetti qui coltivato da sempre per l’incredibile equilibrio tra acidità e corredo polifenolico che lo rendono unico per la sua rigidità nei primi anni, che poi si declina in una inesauribile longevità. I terrazzamenti vitati di Riccardo e Bianca, sono rigorosamente a pergola canavese. Camminarci dentro è una esperienza unica, con muri di sostegno alti fino a sette metri dove in alcuni massi si vede ancora il foro della mina. Bianca descrive con entusiasmo tutte le altre varietà presenti nel suo vigneto come il Neretto Gentile, la Barbera, la Vernassa o Neiret Picul Rus, il Chatus o Nebbiolo di Dronero, la Croatina e l’Uva Rara insieme a tante altre, alcune ancora completamente sconosciute, ma in osservazione nel campo collezione di Grinzane Cavour curato da Anna Schneider e Stefano Raimondi.
La cantina è un luogo semplice ed essenziale, dove si segue il concetto della minima enologia. La filosofia enologica di Riccardo è che solo con la massima qualità delle uve si possono produrre vini di alta gamma. Con tutte le varietà disseminate nel vigneto, come era in uso nel vigneto contadino di una volta, produce un rosso di eccellente qualità il Chemp, affinato in acciaio per due anni e fermentato con lieviti indigeni, un vino di grande freschezza estremamente gradevole ed espressivo. Ma tutto il loro entusiasmo si respira nel Toppia, un Nebbiolo Picotendro in purezza.
Il colore è di un bel rosso rubino, con un profumo fine, fruttato e floreale di ottima persistenza, in bocca la trama tannica si esprime al meglio con un gusto bilanciato ricco e armonico. Due vini nei quali la cura e la passione si sintetizzano nel loro elogio alla lentezza: ‘dare il tempo al vino’.
Per gentile concessione dell’Associazione G.R.A.S.P.O. (Gruppo di Ricerca Ampelografica per la Salvaguardia e la Preservazione dell’Originalità e biodiversità viticola) iniziamo a pubblicare una serie di articoli tratti dal volume 100 CUSTODI PER 100 VITIGNI, LA BIODIVERSITÀ VITICOLA IN ITALIA a cura di Aldo Lorenzoni; testi di Aldo Lorenzoni, Luigino Bertolazzi, Giuseppe Carcereri De Prati, Gianmarco Guarise, Ivano Asperti, Giacomo Eccheli, Elia Quarzago, Marta De Toni, Theresa Balaara.








